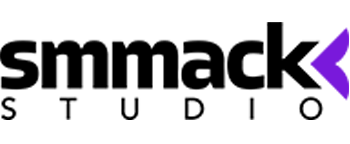C’è un suono che una volta svegliava le case italiane: quello del borbottio della moka sul fuoco, preludio a un aroma intenso che si diffondeva nelle cucine come un rito quotidiano. Oggi, quel suono si sente sempre meno. La moka, simbolo indiscusso della cultura gastronomica italiana, sta lentamente scomparendo dalle nostre abitudini, soppiantata da capsule, macchine automatiche e bar sempre più affollati.
Inventata da Alfonso Bialetti nel 1933, la moka non è solo un oggetto di design — tanto da meritare un posto al MoMA di New York — ma è soprattutto un gesto, un’attesa, un tempo sospeso che molti italiani stanno dimenticando. Preparare il caffè con la moka significa riappropriarsi di un piccolo rituale domestico: dosare l’acqua, livellare il caffè, chiudere con attenzione, accendere il fuoco e aspettare. Nessun bottone da premere, nessuna app da impostare. Solo silenzio, calore, e il profumo che cresce piano.
Eppure, negli ultimi anni, le vendite della moka sono crollate. Le nuove generazioni preferiscono la rapidità delle cialde o il comfort delle macchine a leva. In una società dove tutto dev’essere immediato, anche il caffè ha perso la sua lentezza. Ma cosa perdiamo, insieme a questa semplicità?
La moka è parte del nostro patrimonio culturale quanto la pasta fatta in casa o il sugo della domenica. È un oggetto che unisce generazioni, che racconta storie familiari, che rappresenta l’arte tutta italiana di trasformare anche i gesti più semplici in atti di bellezza. È anche sostenibile, economica, durevole. È, in fondo, un pezzo della nostra identità.
Forse è tempo di riscoprirla. Non per nostalgia, ma per consapevolezza. Rimettere la moka sul fuoco potrebbe essere un piccolo atto di resistenza culturale. Un modo per dire che la nostra storia conta, anche nei gesti più quotidiani.
Il caffè fatto con la moka non è solo una bevanda: è casa.